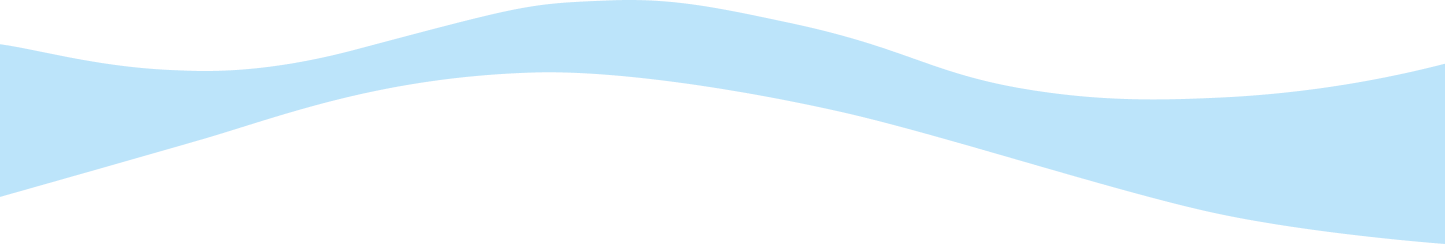L’AGCM si pronuncia sul terzo pilastro della miniriforma del servizio di noleggio con conducente: il cosiddetto «decreto piattaforme»
L’Autorità garante della concorrenza e del mercato il 4 novembre scorso ha espresso il proprio parere sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, recante la «Disciplina dell’attività delle piattaforme tecnologiche di intermediazione tra domanda e offerta di autoservizi pubblici non di linea ai sensi dell’art. 10-bis, comma 8, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019 n. 12», già, peraltro, oggetto, di una segnalazione congiunta con l’ART, risalente al giugno del 2024 (AS 1990 – Servizi di trasporto pubblico non di linea tramite taxi e noleggio con conducente, in Bollettino n. 24 del 12 giugno 2024). In tale atto (pubblicato in Bollettino n. 3 del 27 gennaio 2025) l’Authority, dopo aver contestualizzato il servizio di trasporto con conducente nel mercato di riferimento, ha individuato tre profili di criticità concorrenziale nello schema di dPCM sottoposto al suo esame dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, concernenti: (a) il tempo minimo di attesa per l’erogazione del servizio di trasporto NCC con inizio da un luogo diverso dalla rimessa, (b) le modalità di utilizzazione delle app per la prenotazione dei servizi di autotrasporto ed, infine, (c) la necessità di un uso non esclusivo delle piattaforme tecnologiche di intermediazione per i vettori.
Con riferimento al primo profilo di criticità, l’AGCM si è espressa in favore dell’eliminazione del termine di attesa di venti minuti, decorrenti dal momento della prenotazione del servizio di trasporto da parte dell’utente a quello della sua erogazione, che è stato imposto agli operatori NCC dall’art. 5, comma 2, dello schema di dPCM. Ciò, in quanto, la disposizione, oltre ad introdurre un’ingiustificata barriera all’accesso al mercato ed allo sviluppo del servizio NCC, difetterebbe di ragionevolezza e proporzionalità rispetto all’obiettivo dichiarato e perseguito dal legislatore, consistente nel preservare la specificità del bacino di utenza di siffatta tipologia di autotrasporto, rispetto al servizio taxi. Allo stato della disciplina vigente, l’impossibilità per gli operatori NCC di rivolgere i propri servizi ad un’utenza indeterminata sarebbe, invero, già adeguatamente garantita sia dall’obbligo di ricevere le richieste di servizio e le prenotazioni – anche mediante l’impiego di strumenti tecnologici – presso la sede o la rimessa, che da quello di compilazione e di tenuta del foglio di servizio elettronico, dal quale è sempre possibile evincere l’esistenza della prenotazione di un successivo trasporto. La previsione potrebbe, poi, anche indurre gli operatori NCC a tornare in rimessa prima di eseguire un successivo servizio, nullificando, così, i benefici effetti derivanti dall’utilizzo delle applicazioni digitali, sia dal lato della domanda, che da quello dell’offerta di dislocamento. Ed una simile scelta operativa finirebbe per ledere non soltanto gli interessi dei consumatori, rendendo loro più difficile il soddisfacimento della sempre crescente domanda di mobilità, ma anche la libertà di stabilimento, codificata nell’art. 49 TFUE.
Quest’ultima, secondo quanto chiarito dalla Corte di giustizia, è suscettibile di compressioni «solo a condizione» che queste siano «giustificate da un motivo imperativo di interesse generale» nel rispetto del principio di proporzionalità (C. giust. UE 8 giugno 2023, causa C-50/21), elementi non ricorrenti nella fattispecie, ove le limitazioni alla predetta libertà sembrerebbero essere giustificate da ragioni di «carattere puramente economico» e lesive di una pluralità di interessi generali, come quello alla tutela ambientale, che un contenimento dei «viaggi a vuoto» delle autovetture NCC potrebbe, invece, contribuire a realizzare.
In ordine, poi, alle modalità di utilizzo delle piattaforme tecnologiche che svolgono attività di intermediazione, congiuntamente per i servizi taxi e quelli NCC, l’AGCM ha ritenuto che la previsione contenuta nell’art. 6, comma 1, dello schema di dPCM, secondo la quale gli utenti sono tenuti ad esercitare «una opzione espressa del servizio taxi o NCC» prima «dell’invio di ciascuna richiesta di servizio intermediato» appare ostativa al libero esplicarsi delle regole della concorrenza e vada, quindi, espunta dal decreto, giacché rischia di canalizzare le richieste verso il servizio meno costoso, quello taxi, pregiudicando, così, quello NCC, che, come noto, si contraddistingue per presentare standard qualitativi più elevati. La disposizione non sarebbe, quindi, idonea ad incrementare la concorrenza tra le due tipologie di trasporto pubblico locale, la sola che potrebbe indurre i vettori NCC a rivedere al ribasso il corrispettivo dei propri servizi, tanto più considerato che queste due modalità di dislocamento sono oggigiorno percepite, dai rispettivi utenti, come tra di loro intercambiabili. La norma impedirebbe, quindi, ai consumatori che si avvalgono delle piattaforme digitali di poter effettuare una scelta economica pienamente consapevole, che, invece, potrebbe essere assicurata laddove sulla schermata del device utilizzato per la prenotazione fosse visualizzabile tutta l’offerta di trasporto disponibile in quel determinato momento sulla piattaforma.Considerato, poi, che la prenotazione di per sé non rappresenta un elemento imprescindibile del servizio taxi, anche nel caso di prestazione di trasporto ritardata rispetto alla richiesta, la permanenza della previsione nello schema di decreto non potrebbe neanche essere giustificata per la necessità di assicurare che il servizio di noleggio con conducente abbia ad oggetto un’utenza specifica e non generalizzata.
L’eccessivo sbilanciamento della norma in favore del servizio taxi, secondo l’AGCM, non troverebbe neanche un adeguato correttivo, nel disposto dell’art. 4, comma 3, dello schema di decreto, che impone ai gestori delle applicazioni di prenotazione di adottare «appositi presidi volti a garantire che la destinazione dell’utente sia comunicata al vettore taxi solo al momento» del suo prelievo e che l’operatore non sia informato del corrispettivo della corsa. Se, infatti, quest’ultima disposizione è preordinata ad evitare che i vettori taxi possano rifiutare le corse meno remunerative, essa comunque non rappresenta un adeguato deterrente per il corretto assolvimento degli obblighi di servizio pubblico che su quelli gravano, dal momento che non può impedire il verificarsi di fattispecie di rifiuto ingiustificato del trasporto, obiettivo conseguibile, invece, laddove, nell’eventualità paventata, essa imponesse al gestore dell’applicazione di sollecitare l’esercizio delle funzioni di vigilanza da parte dell’ente territoriale competente per il servizio taxi.
Da ultimo l’AGCM ha, anche, auspicato che nel provvedimento sia inserita una specifica previsione che legittimi gli operatori taxi ed NCC ad avvalersi di più di una piattaforma tecnologica, prevedendo la nullità di qualsiasi clausola o pattuizione contrattuale contraria, al fine di favorire un efficace confronto competitivo tra le strutture che intermediano tra la domanda e l’offerta di autotrasporto, tema sul quale già nel 2020 è intervenuto il Consiglio di Stato (C. Stato, sez. VI, 24 novembre 2011 n. 6204) che ha rimarcato come simili clausole di esclusiva oltre ad impedire od ostacolare l’ingresso nel mercato di nuovi operatori, inducono anche una riduzione qualitativa e quantitativa del servizio erogato all’utenza, nonché l’aumento dei prezzi dei servizi intermediati.